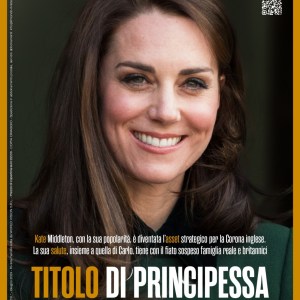Verso lo stop del test di ammissione a Medicina. L’Ordine dei medici: “produrremo disoccupati”. Marti (Lega): “stesse opportunità per tutti gli studenti”
Viviamo in un mondo che cambia rapidamente, ma certi stravolgimenti fanno più rumore di altri. È il caso del test di ammissione a Medicina, una delle università più complesse in Italia, non solo per il percorso accademico da compiere ma anche per il test di ammissione da affrontare, che di anno in anno premia o taglia le gambe a migliaia di ragazzi in tutta la Penisola. Uno scoglio che sta per essere rimosso, notizia che fa ben sperare molti e che tedia invece molti altri. Il Comitato ristretto della Commissione Istruzione del Senato, infatti, ha approvato quasi all’unanimità il testo base per la riforma che dall’anno 2025/26 toglierà il numero chiuso a Medicina. Lo ha annunciato il presidente della Commissione, l’esponente della Lega Roberto Marti, che ha parlato di “molta soddisfazione” per l’adozione del testo esame e della “massima convergenza” di “tutte le forze politiche”. Il testo stabilisce che a partire dal 2025 sarà possibile iscriversi al primo semestre di Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria senza sostenere alcun test d’ingresso; la prima valutazione arriverà dunque per il passaggio al secondo semestre: gli studenti dovranno superare gli esami in area biomedica, sanitaria, farmaceutica e veterinaria per poter proseguire, conseguendo tutti i Cfu previsti e collocandosi in una posizione adeguata nella graduatoria nazionale, altrimenti potranno utilizzare i crediti formativi acquisiti fino a quel momento per spostare l’iscrizione a un corso di laurea differente. Il Governo dovrà adottare “uno o più” decreti legislativi per rivedere le modalità di accesso ai corsi di laurea entro 12 mesi dall’approvazione della legge.

Il testo della riforma
L’obiettivo dichiarato del Governo con questo cambio radicale nel processo di selezione e formazione dei futuri medici è quello di riordinare l’offerta formativa universitaria in modo da garantire “elevati standard di qualità” e supportare le aree di specializzazione “con carenze di personale”. Obiettivo che sarà perseguito potenziando le capacità ricettive delle università e introducendo un sistema di monitoraggio delle necessità di personale del servizio sanitario nazionale, in collaborazione con il ministero della Salute.
Il testo prevede anche l’attuazione di un miglioramento dell’orientamento e della preparazione agli studi universitari durante l’ultimo triennio negli istituti secondari di secondo grado, con l’introduzione di tirocini e un maggior grado di attenzione alle competenze trasversali. L’obiettivo è avere giovani più preparati dopo il diploma ad affrontare il mondo oltre il liceo, con una maggior collaborazione tra università e scuole anche sotto forma di guida di tutor qualificati per preparare i futuri studenti ai rigori dei corsi di laurea magistrale.
Il percorso per diventare un medico è arduo, anche una volta superato il test d’ingresso. Una volta arrivati alla specializzazione, gli aspiranti chirurghi devono vincere un concorso nazionale del ministero dell’Istruzione e ottenere una borsa di studio per poter praticare una specializzazione in ospedale. A quel punto, possono partecipare ai concorsi per essere assunti a tempo indeterminato dal servizio sanitario nazionale: il percorso dunque rimane tortuoso e decisamente lungo anche se la prima vera “barriera” viene spostata di un semestre. In sostanza l’ingresso a numero chiuso ai dipartimenti unitamente al numero di borse di studio messo a disposizione annualmente (risultato di un lavoro di programmazione non sempre lineare) determinano la quantità di medici che effettivamente potranno lavorare in futuro negli ospedali o sul territorio come medici di base. Questo va a scontrarsi però con la carenza di personale negli ospedali stessi: da qui l’idea di “rimandare” il test d’ingresso.

Dissenso dei medici, intervista al presidente del Fnomceo Filippo Anelli
La Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri (Fnomceo) si è detta fortemente contraria alla riforma, perlomeno in alcune delle sue parti, a partire proprio dal test di ammissione. Per comprendere meglio il testo, Il Mondo ha intervistato il presidente del Fnomceo, il dottor Filippo Anelli.
Dottor Anelli, quali sono i pro e i contro di questa riforma?
«Come in tutte le riforme, ci sono cose positive e cose negative. Il risvolto positivo riguarda la programmazione, in ragione del fabbisogno del Servizio sanitario nazionale e della disponibilità di posti nel percorso post laurea. L’aspetto negativo invece riguarda il semestre libero, che non significa che ci sarà “ingresso libero” a Medicina, ma che i ragazzi potranno accedere liberamente al primo semestre, preparandosi su quattro materie: tre sono già note, saranno chimica, fisica e biologia, la quarta potrebbe essere anatomia. Dopodiché, sulla base dei CFU conseguiti e del voto ottenuto, verrà costituita una graduatoria per l’accesso al secondo semestre e l’iscrizione effettiva al corso di Medicina».
Quali potrebbero essere i problemi di questo modus operandi?
«Ci sono svariati handicap. Intanto, la graduatoria verrebbe fatta in ragione del voto conseguito quindi ci potremmo trovare di fronte a ragazzi che hanno superato tutti gli esami ma che non si sono collocati in maniera utile in graduatoria. Inoltre, ogni anno gli accessi per l’iscrizione a medicina sono tra i 60 e gli 80mila, un numero enorme che l’università non può sopportare. La struttura non è adeguata a reggere questo afflusso, si sta dunque pensando eventualmente di organizzare dei corsi online; si porrebbe quindi un problema di accesso ai laboratori, con una qualità della formazione che è quella dell’online e che per forza differisce dalla presenza fisica e dal rapporto diretto con i medici insegnanti. Un altro tema scottante è la possibile perdita di un anno di studio per tanti ragazzi. Abbiamo un problema generale, in Italia: i nostri ragazzi arrivano sul mondo del lavoro tardi, con un’età maggiore rispetto ai loro coetanei degli altri Paesi. Questo perché intanto il liceo in Europa e nel mondo oggi è fatto di quattro anni e non di cinque; e poi perché la direttiva europea consente agli Stati di poter fare medicina in cinque anni e non in 6 come da noi; spesso, inoltre, i corsi di specializzazione sono di tre anni, non di quattro o cinque come in Italia. Perciò i nostri ragazzi arrivano alla specializzazione e alla laurea tardi e perdere un altro anno potrebbe essere un problema».
Qual è la proposta del Fnomceo?
«Siamo d’accordo sul cambiare la modalità di preparazione per l’accesso a medicina. Concordiamo sul fatto che vada fatta su materie specifiche e che i test molto spesso non siano utili a valutare la qualità dell’effettiva preparazione dei ragazzi che vogliono accedere ai corsi. L’idea perciò è di preparare noi stessi gli studenti su alcune materie, nel corso dell’ultimo anno di scuola superiore, di liceo, con un programma a cura dell’università e svolto a titolo gratuito, anche online, che consenta una buona preparazione ma che sia anche uno strumento di orientamento del ragazzo, per capire se la sua aspirazione coincide con la sua effettiva vocazione».
Non temete che la preparazione al test unitamente alla preparazione all’esame di maturità possa essere un peso eccessivo?
«È un’obiezione che si fa spesso ma la risposta è no. Sono 10 anni che collaboriamo con alcuni licei in Italia per sperimentare una preparazione triennale all’università di Medicina durante la scuola e non abbiamo mai riscontrato grossi problemi. I ragazzi modulano la preparazione al test con la preparazione dell’esame di maturità. Personalmente ritengo che oggi i ragazzi siano molto più preparati che in passato: hanno degli stimoli e degli strumenti diversi, nettamente migliori, e sono nelle condizioni ideali per poter fare le due cose insieme».





Le voci a favore, intervista al sen. Roberto Marti
«È stato un lavoro intenso che ha trovato la massima convergenza di tutte le forze politiche – ha dichiarato il senatore Roberto Marti dopo l’approvazione del testo – l’odioso numero chiuso che abbiamo conosciuto negli ultimi 25 anni non ci sarà più. Un impegno che la Lega aveva preso in campagna elettorale. Un mandato chiaro che ha rappresentato uno stimolo anche nella decisione di assumere l’incarico di presiedere la commissione».
Per fare luce sui nodi più importanti della riforma, Il Mondo ha intervistato proprio Roberto Marti.
Quali sono i punti chiave della riforma e cosa cambia nello specifico?
«Si tratta di un cambiamento importante. Tutti gli studenti che lo desiderino potranno iscriversi liberamente al primo semestre delle facoltà di medicina, odontoiatria e veterinaria. Avranno a disposizione un semestre per dimostrare le competenze acquisite durante quel periodo e nelle discipline oggetto dei corsi che seguiranno. Nel caso in cui lo studente non raggiunga i risultati sperati, potrà proseguire gli studi in un altro corso di laurea che avrà scelto come seconda opzione, vedendosi pienamente riconosciuti gli esami già sostenuti. O, ancora, nel caso in cui lo studente dovesse accorgersi di voler intraprendere un percorso diverso, potrà iscriversi tardivamente a quel corso di laurea senza perdere l’intera annualità. Importantissimo è anche l’orientamento mirato che gli studenti potranno scegliere di fare durante gli ultimi anni della scuola superiore, perché l’elemento vocazionale è di particolare importanza in questo campo di studi»
Quale risultato si augura di raggiungere con questo nuovo modus operandi?
«L’obiettivo è quello di fare una selezione realmente meritocratica offrendo a tutti i ragazzi l’opportunità di misurare passione e competenze sul campo»
La critica principale che viene mossa al testo riguarda l’impossibilità dell’università di sostenere un numero così alto di iscritti per il primo semestre, si parla di “formazione online” ma naturalmente questo rende complicata la partecipazione ad esempio ai laboratori: come pensate di arginare il problema?
«Saranno le università stesse a scegliere le modalità più opportune per gestire un numero più elevato di alunni. Trattandosi di una materia così specifica e complessa, abbiamo ritenuto opportuno affidare al governo una legge delega che, tra l’altro, permetta di definire anche le discipline oggetto di studio nel primo semestre e, certamente, garantire a tutti gli studenti una elevata qualità di formazione»
Gli studenti che non riusciranno a passare il semestre, o che lo passeranno ma non raggiungeranno una posizione in graduatoria tale da poter accedere effettivamente al corso di laurea, non rischieranno di perdere un anno importante, considerando anche che i nostri giovani entrano nel mercato del lavoro già molto più tardi rispetto ai colleghi europei, ad esempio?
«Assolutamente no, è proprio questa una delle novità più rilevanti. Lo studente che non riuscirà a iscriversi al secondo semestre di medicina, odontoiatria e veterinaria sarà già iscritto al secondo semestre della sua facoltà di seconda scelta. Attraverso un lavoro meticoloso di coordinamento tra gli Atenei, la maggior parte delle materie del primo semestre dei corsi di laurea di area biomedica saranno ‘assimilabili’, dunque i ragazzi non perderanno tempo, diversamente da quanto accade oggi»
I colleghi del Fnomceo propongono un cambio nella preparazione al test più che nel test stesso: ritiene possibile mettere in atto una strategia di formazione durante l’ultimo anno di scuola superiore nelle materie principali (chimica, fisica, biologia, anatomia), o ritiene che questo possa in qualche modo compromettere la preparazione dell’esame di maturità dei ragazzi?
«Credo sia indispensabile assicurare a tutti gli studenti, su tutto il territorio nazionale, le stesse opportunità. Spesso, un ragazzo pronto a diventare un medico non matura questa consapevolezza durante il liceo. Certamente, e infatti lo abbiamo previsto, tutti gli studenti del triennio devono avere a disposizione percorsi finalizzati all’orientamento e allo sviluppo della propria vocazione in questo ambito, nelle ore dedicate ai PCTO. Non dobbiamo preoccuparci che i nostri ragazzi inizino l’università già con una buona conoscenza di base della chimica o della biologia ma che siano consapevoli della fatica e del sacrificio che li attende per poi arrivare a pronunciare il giuramento di Ippocrate».
Test di ammissione 2024
Per l’anno in corso, comunque, le modalità di accesso a tutti e tre i corsi in lizza per il cambiamento (Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria) rimangono invariate. I test di ammissione sono previsti il 28 maggio e il 30 luglio 2024 per Medicina e Chirurgia e Odontoiatria, mentre si terranno il 29 maggio e il 31 luglio per Medicina veterinaria. Gli aspiranti studenti avranno la possibilità di partecipare a entrambe le sessioni di esame. Le prove – che avverranno in forma cartacea – constano di 60 domande multiple scelte da una banca dati pubblica che contiene circa 7mila quesiti. Ogni esame dura 100 minuti e copre svariate aree tematiche: competenze di lettura, ragionamento logico, biologia, chimica, fisica e matematica. I candidati devono selezionare una risposta esatta tra cinque opzioni proposte per ogni domanda. Per essere considerati idonei all’ammissione bisogna raggiungere un punteggio minimo di 20 punti, la valutazione massima raggiungibile è di 90 punti, con 1,5 punti assegnati per ogni risposta corretta e una penalizzazione di 0,4 punti per ogni errore. Le risposte omesse danno invece zero punti. La graduatoria verrà compilata tenendo conto del miglior punteggio ottenuto dal candidato nelle due sessioni del test, in modo da ottimizzare le opportunità di ammissione di tutti i partecipanti.
di: Micaela FERRARO
FOTO: ANSA